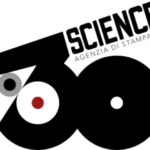Roma – Si chiama GroceryDB ed è un ampio studio che raccoglie oltre 50.000 cibi processati presenti sugli scaffali alimentari americani e che sono parte integrante della dieta, pressoché quotidiana, degli statunitensi. Cibi poco sani che favoriscono lo sviluppo di numerose patologie: disturbi metabolici, patologie croniche, tumori del colon-retto o gastrici per citare alcuni dei principali rischi correlati. Lo studio, iniziato nel periodo pandemico sviluppato da ricercatori del Mass General Brigham, con alla guida l’italiana Giulia Menichetti, dà oggi i suoi frutti offrendo importanti e numerosi dati, necessari anche alla definizione di potenziali strategie di intervento sul singolo individuo e in ottica di miglioramento della salute pubblica. Lo studio è pubblicato sulla rivista Nature Food ed è disponibile al pubblico.
“Il progetto nasce con l’obiettivo di andare a colmare alcune delle lacune ancora esistenti fra la nutrizione e le diverse scienze che contribuiscono alla medicina personalizzata come la genomica, stante che i geni hanno un ruolo chiave nel determinare la predisposizione al possibile sviluppo di specifiche malattie” spiega la ricercatrice. “Le informazioni ad oggi raccolte confermano l’importante interazione e interrelazione fra malattie, ambiente e qualità dell’alimentazione dove i geni influiscono solo nel 10-20% dei casi, da analisi statistiche che abbiamo condotto, nell’influenzare malattie e mortalità”. La ricchezza dei dati, di strumenti di Intelligenza Artificiale permettono di costruire, allenare e migliore modelli per analizzare e studiare queste correlazioni: ecco l’importanza di studi come GroceryDB e della piattaforma correlata TrueFood, che analizza la composizione degli alimenti presenti nei supermercati, consumati della popolazione tutti i giorni. “Il nostro obiettivo è favorire la formazione di una “cultura del dato”, che sottolinei l’importanza della condivisione dei dati stessi, analizzati da un pool di differenti expertise per studiare efficaci sinergie e strategie di intervento. Dati che, infine, permetteranno la creazione di Large Language Model (LLM) per la nutrizione, sulla falsariga di quelli applicati al linguaggio umano, ad esempio in ChatGpt, e alla biologia per la creazione di proteine, per la comprensione del DNA e molto altro. La magnitudo di dati, necessari per l’analisi di tutti questi aspetti e che rappresenta un valore aggiunto per molte scienze, in nutrizione è ancora molto lontana”. Sulla base di questa evidenza scientifica, della necessità di fare data-science e dell’aumentato dell’interesse scientifico verso i cibi ultraprocessati, soprattutto da parte degli epidemiologi, è stato sviluppato dai ricercatori un modello sufficientemente flessibile per generare nuovi dati in ambito nutrizionale, oggi scarsi, che consentono di aumentare la riproducibilità dei risultati. “Abbiamo ideato un algoritmo per creare dei ranking specificatamente in ambito di alimenti processati, considerata l’alta percentuale di questa categoria nella catena alimentare. È fondamentare che queste iniziative educazionali entrino nelle scuole, in quanto è più facile plasmare le abitudini alimentari di un bambino, rispetto a quelle già consolidate nell’adulto e che legano allo status socio-economico e culturale, a cui va suggerito fra le opzioni di uno stesso alimento disponibile la meno peggio per la salute. Si tratta dunque di fare una azione di salute pubblica, coinvolgendo non solo il consumatore, ma a monte anche coloro che raccolgono e analizzano i dati, le aziende nel modo di presentare i dati stessi e le informazioni: occorre creare una sorta di Osservatorio a 360°. Penso specificatamente a quelli che noi definiamo “ambienti alimentari”: anche la persona più virtuosa se non dispone di alimenti sani, si troverà esposta nel corso del tempo a problemi di salute”. Il punto di incontro migliore tra consumatore e cibo e il più efficace su cui agire è il supermercato che diventa anche il termometro per misurare le abitudini di consumo e le preferenze della popolazione generale. L’analisi dei dati ha fatto ad esempio osservare una stretta relazione fra il costo e il livello di processazione di un cibo, dove in generale e nella maggior parte delle categorie, più un cibo è processato più è economico, indicando che persone con scarsi mezzi economici tenderanno a consumare più cibo processati, come le zuppe ad esempio. Esiste però anche una relazione inversa: in alcune categorie come gli snack o il latte alternativo, che sono fra i più processati, tendono ad essere tra i cibi più costosi. Gli ultraprocessati non impattano dunque solo su certe fasce di reddito ma anche su nuove abitudini alimentari. “Sta crescendo il numero di persone che seguono una dieta Plant-Based, di impostazione vegana, in cui però si osserva la tendenza non a cambiare radicalmente il proprio stile di vita e il regime alimentare, assumendo quindi più frutta e verdure fresche, ma optando solo per alimenti ultraprocessati ma plant-based. Il rischio è che si finisca con il consumare quantità superiori di questa tipologia di cibi rispetto a prima, innescando a catena conseguenze sulla salute” aggiunge Giulia Menichetti.
Obiettivo dei ricercatori è ora migliorare ulteriormente i modelli e arrivare a categorizzare i cibi ultraprocessati sulla base dei processi cui sono sottoposti e quindi la tipologia di cibi che presentano reali rischi per la salute. Questo obiettivo si lega anche alla necessità di fare più ricerca, avviare esperimenti e trial clinici, avere dati robusti che consentano di dare una corretta definizione di cibo ultraprocessato all’interno delle Linee Guida, lavorando poi sulla popolazione. “Il terreno più fertile per la diffusione di questi dati è l’Europa, tenuto anche conto che siamo il prodotto della nostra catena alimentare e la prova del nove è fornita dal cambiamento in peggio dell’alimentazione delle nuove generazioni che ha favorito la crescita di tumori negli under 50, spesso associati al tipo di dieta seguito. Oltre a fare divulgazione, a implementare le collaborazioni con Università e enti italiani, il mio auspicio è di poter sviluppare una iniziativa equivalente a questa in Italia per valutare cosa c’è sugli scaffali dei “nostri” supermercati, fare una comparazione con le altre nazioni e da qui pensare a strumenti di salute pubblica e a come portarli al consumatore o a come renderli parte della salute pubblica stessa” dichiara la ricercatrice.
In Italia si potrebbe ipotizzare un intervento sulla popolazione con libero accesso all’informazione che riguardano i cibi (ultra)processati, imitando uno studio già condotto dal team di ricerca che ha definito degli score per specifico cibo e rischi per malattie, per esposizione a contaminanti come le microplastiche o altri agenti cancerogeni legati a processi di lavorazione e di cottura, tra cui le alte temperature, l’impatto in termini di invecchiamento biologico, la quantità di vitamine presenti nel sangue, ricavando per ognuno di questi aspetti una associazione statistica. “Tale approccio”, conclude Giulia Menichetti, “consente di valutare cosa cambia in termini di salute o di altri fattori con l’aumento o la diminuzione delle quantità di cibi processati. Applicando questo score nella popolazione e pilotando gradualmente le scelte alimentari, abbiamo osservato che cambiando anche un singolo cibo di ha una riduzione del rischio di malattia, una variazione della biodisponibilità delle molecole, come le vitamine ad esempio. L’auspicio è che modesti interventi sulla popolazione possano dare un grande risultato a livello di salute pubblica”.(30Science.com)