Roma – L’azione di una sola proteina, chiamata NOVA1, potrebbe essere all’origine dello sviluppo e dell’evoluzione del linguaggio parlato, secondo uno studio della Rockefeller University, Stati Uniti, pubblicato su Nature Communications, che contribuisce a chiarire aspetti di questa facoltà, da sempre indagata. Lo studio avrebbe determinato che la nostra specie condivide con gli Homo sapiens, tra cui l’uomo di Neanderthal, una variante genica, nello specifico una proteina che apparterebbe solo all’uomo, per altro anche l’unica specie che mostra l’espansione di specifiche regioni cerebrali, ritenute cruciali per la produzione e la comprensione del linguaggio. Una serie di esperimenti su topi sembrano dimostrare che la variante genica NOVA1, una proteina legante l’RNA, esclusiva dell’uomo, inserita in aree cerebrali fondamentali per lo sviluppo neurale, altera le vocalizzazioni (gli squittii) con cui gi animali si chiamano a vicenda. Lo studio ha inoltre confermato che questa variante non si trova né nei Neanderthal né nei Denisova, esseri umani arcaici con cui i nostri antenati si sono incrociati, come dimostrano le tracce genetiche che sono reperite in molti genomi umani. “Questo gene fa parte di un radicale cambiamento evolutivo nei primi esseri umani moderni e suggerisce potenziali origini antiche del linguaggio parlato”, afferma il dottor Robert Darnell, responsabile del Laboratorio di neuro-oncologia molecolare. “NOVA1 potrebbe essere un autentico gene del linguaggio umano, anche se certamente è solo uno dei tanti cambiamenti genetici avvenuti nella specie umana”. Gli adattamenti anatomici del tratto vocale e le complesse reti neurali hanno poi premesso e favorito nell’uomo lo sviluppo delle capacità linguistiche, di cui si sta studiando la componente la genetica. Tra le varie ipotesi si teorizza che fra i principali driver genetici ci via FOXP2, che codifica per un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo precoce del cervello. Mutazioni in questo gene causerebbero infatti gravi difetti del linguaggio, tra cui l’incapacità di coordinare i movimenti delle labbra e della bocca con il suono. In particolare nell’uomo, e in nessun’altra specie primati o mammiferi, esisterebbero due sostituzioni di amminoacidi in FOXP2 condivisa solo con i Neanderthal, suggerendo che la variante sia emersa in un antenato di entrambe i lignaggi umani. Questa teoria è stata però messa spesso in discussione, aprendo la via al ruolo di NOVA1, il gene che produce una proteina legante l’RNA specifica dei neuroni, fondamentale per lo sviluppo del cervello e il controllo neuromuscolare. NOVA1 è stata clonata e caratterizzata per la prima volta da Darnell nel 1993, reperita in forma identica in un’ampia fascia della biosfera, dai mammiferi agli uccelli, ma non negli esseri umani. Nell’uomo assumerebbe una forma tipica, caratterizzata da un singolo cambiamento di un amminoacido, da isoleucina a valina, in posizione 197 (I197V) nella catena proteica. Tuttavia, I197V non è sembrerebbe l’unica sostituzione di amminoacidi che distingue gli esseri umani moderni da altri organismi, molti altri cambiamenti potrebbero avere avuti un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del cervello, contribuendo all’insorgenza, all’espansione e alla sopravvivenza dell’Homo sapiens. Ricerche su NOVA1, condotte fin dai primi anni ’90, sembrano identificare per la prima volta questa proteina come elemento scatenante per un disturbo neurologico autoimmune che può causare una grave disfunzione motoria e più di recente le varianti genetiche di NOVA1 sarebbero state associate a difficoltà motorie e linguistiche evolutive. L’attuale studio ha utilizzato l’editing genetico CRISPR per sostituire la comune proteina NOVA1 trovata nei topi con la variante umana I197V e tramite tecniche avanzate come l’analisi di immunoprecipitazione con cross-linking (CLIP), un metodo sviluppato da Darnell, utilizzate per identificare i siti di legame dell’RNA di NOVA1 nel mesencefalo del topo. È stato così possibile scoprire che la variante umana non ha alcun impatto sul legame dell’RNA correlato allo sviluppo neurale o al controllo motorio e che i siti di legame che erano interessati dalla variante umana erano localizzati in geni che codificavano per RNA correlati alla vocalizzazione. Ulteriori esperimenti che hanno indagato l’impatto sulle vocalizzazioni tra topi di età diverse e in contesti diversi, avrebbero identificato modelli vocali alterati sia tra cuccioli di entrambi i sessi che tra maschi adulti. Nello specifico una volta che i ricercatori hanno “traslitterato” (modificato) gli squittii emessi dai topi con la variante I197V specifica per l’uomo, si sono osservate variazioni rispetto a quelli dei topi selvatici. Per confermare che tale variante non fosse rilevabile nei Neanderthal, che vivevano in gran parte in Europa, e nei Denisoviani, che prendono il nome dalla grotta dell’Asia centrale in cui sono stati scoperti, i ricercatori hanno confrontato otto genomi umani con tre genomi di Neanderthal ad alta copertura e un genoma di Denisoviani ad alta copertura. Secondo le attese, i nostri parenti arcaici, dai quali si pensa ci siamo separati circa 250.000-300.000 anni fa, mostravano la stessa proteina NOVA1 di tutti gli animali non umani. Esaminati poi 650.058 genomi umani moderni nel database dbSNP, un catalogo di variazioni di sequenze brevi tratte da persone di tutto il mondo, la variante ad alta copertura è stata reperita in tutti i campioni ad eccezione di sei che presentavano la variante arcaica. I dati sembrano dunque mostrare che una popolazione ancestrale di umani moderni in Africa abbia sviluppato la variante umana I197V, che poi è diventata dominante, una volta lasciato l’Africa e diffusa in tutto il mondo. I ricercatori si dedicheranno ad approfondire la possibile relazione tra NOVA1 che regola la funzione linguistica e i disturbi linguistici o dello sviluppo, ad esempio con l’autismo non verbale, cioè la capacità di comunicare utilizzando gesti, ma ha notevoli difficoltà nell’utilizzo del linguaggio; NOVA1 è infatti uno dei tanti geni collegati al disturbo dello spettro autistico o di altri disturbi dello sviluppo legati alle malattie neurodegenerative.(30Science.com)

30Science.com
L’origine del linguaggio parlato potrebbe essere legata a un’unica proteina
(18 Febbraio 2025)
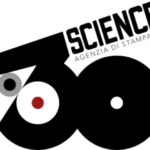
30Science.com
Agenzia di stampa quotidiana specializzata su temi di scienza, ambiente, natura, salute, società, mobilità e tecnologia. Ogni giorno produciamo una rassegna stampa delle principali riviste scientifiche internazionali e quattro notiziari tematici: Scienza, Clima & Natura, Salute, Nuova Mobilità e Ricerca Italiana
contatti:
redazione@30science.com
+ 39 3492419582