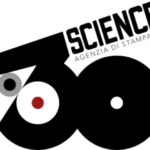Roma – Le scorie nucleari rappresentano uno dei problemi più delicati della transizione energetica verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Tra i materiali più pericolosi e persistenti vi è lo iodio-129 (I-129), un isotopo radioattivo con un’emivita di 15,7 milioni di anni, capace di migrare facilmente nell’ambiente e di accumularsi nella tiroide umana. Un nuovo studio pubblicato su Nature Sustainability da un team del Massachusetts Institute of Technology (MIT) analizza per la prima volta, su scala globale, l’impatto ambientale delle diverse strategie di gestione del combustibile nucleare esaurito, evidenziando quello che gli autori definiscono il “paradosso dello iodio-129”.
Secondo la ricerca, condotta da Haruko M. Wainwright e Kate Whiteaker del MIT, insieme a scienziati di diversi laboratori nazionali statunitensi, le politiche di smaltimento del combustibile nucleare seguono due approcci opposti: da un lato, il modello statunitense, basato sul confinamento in depositi geologici profondi, che mira a isolare i radionuclidi per tempi lunghissimi; dall’altro, l’approccio francese, fondato sul riprocessamento del combustibile e sul rilascio controllato di effluenti radioattivi a basso livello nel mare. Una terza opzione, più recente, prevede l’uso di filtri per catturare lo iodio-129, che viene poi smaltito in depositi superficiali.

Rafael Mariano Grossi, IAEA Director General, tours Onkalo, the world’s first ever deep geological repository for spent fuel, during his official visit to Finland.
Il confronto quantitativo tra queste strategie ha prodotto risultati netti. I ricercatori hanno calcolato che il sistema francese di riciclo e rilascio comporta la dispersione nell’ambiente di oltre il 90% dello iodio-129 contenuto nel combustibile, con una media di 4,5 chilogrammi rilasciati per ogni gigawatt di elettricità prodotta in un anno. La soluzione statunitense di smaltimento diretto, invece, ne libererebbe appena 2×10⁻⁸ chilogrammi sullo stesso intervallo temporale, ovvero otto ordini di grandezza in meno, e solo dopo circa mille anni dal deposito iniziale, in caso di rottura delle barriere di contenimento.
Sebbene le concentrazioni misurate nelle acque marine europee restino inferiori ai limiti di sicurezza, le analisi effettuate nei pressi dei siti di riprocessamento di La Hague (Francia) e Sellafield (Regno Unito) confermano la presenza diffusa di tracce di iodio-129 nel Canale della Manica e nel Mare del Nord. Negli Stati Uniti, al contrario, i livelli più elevati si registrano nei pressi di Hanford, nello Stato di Washington, dove i rifiuti nucleari del programma bellico del XX secolo non furono adeguatamente isolati.
“Il nostro lavoro – spiega Wainwright – mostra come le scelte di gestione del combustibile influenzino direttamente la quantità e la tempistica del rilascio dei radionuclidi. Le pratiche di riciclo con diluizione isotropica possono sembrare innocue, ma trasferiscono il problema all’ambiente presente. Lo smaltimento profondo lo rinvia di milioni di anni, riducendo la dispersione ma creando rischi localizzati legati all’integrità delle barriere nel tempo.”
Il “paradosso” identificato dagli autori nasce dal confronto tra due logiche opposte: la “diluizione”, che accetta la dispersione immediata in mare in concentrazioni molto basse, e l’“isolamento”, che punta a confinare totalmente le scorie sottoterra. Entrambi i modelli, sottolineano gli scienziati, hanno punti di forza e limiti: il primo minimizza i rischi locali ma contribuisce alla diffusione globale di contaminanti persistenti; il secondo riduce drasticamente il rilascio, ma richiede garanzie di sicurezza tecnologica e politica su scale temporali superiori all’intera storia dell’umanità.
La ricerca del MIT propone una visione più ampia della gestione dei rifiuti radioattivi, che non si limiti alla riduzione del volume delle scorie, ma consideri la mobilità, la persistenza e la destinazione finale dei radionuclidi. “È essenziale includere gli effluenti liquidi come parte integrante del problema – afferma Wainwright – e valutare in modo trasparente gli effetti ambientali e sociali delle diverse opzioni. L’eccessiva cautela normativa, se mal calibrata, rischia di scoraggiare soluzioni più sicure e innovative.”
Lo studio invita inoltre a guardare oltre il caso dello iodio-129, proponendo un approccio sistemico alla gestione dei contaminanti persistenti, dai radionuclidi ai composti industriali come mercurio, PFAS o CO₂. “La storia dell’ambiente ci insegna – aggiunge l’autrice – che sostanze considerate ‘gestibili’ attraverso la dispersione hanno spesso avuto conseguenze inattese nel tempo. L’industria nucleare, invece, ha sviluppato strategie di isolamento avanzate sin dagli anni ’50, che oggi possono diventare un modello per altri settori.”
Il lavoro, sostenuto dal MIT Climate Fast Forward Faculty Fund e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, fornisce uno strumento quantitativo per orientare le politiche energetiche e ambientali globali. Gli autori concludono che una strategia di gestione efficace delle scorie nucleari dovrà bilanciare l’efficienza economica, la trasparenza pubblica e la responsabilità intergenerazionale, trasformando la “diluizione del rischio” in una vera cultura dell’isolamento controllato e sostenibile.(30Science.com)