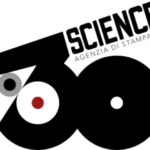Roma – Circa cinquanta esemplari adulti trasferiti in Aree Marine Protette, 200 chilometri di costa scandagliata palmo a palmo alla ricerca di individui vivi, 100 giornate di immersioni per i monitoraggi e più di 60 scienziati provenienti da tutti i Paesi mediterranei coinvolti. Sono questi i numeri raggiunti da LIFE Pinna, il progetto europeo nato per salvare dall’estinzione la Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mar Mediterraneo.
Un programma d’intervento e ricerca che, dopo quattro anni intensi di attività nel Mar Ligure, Mar Tirreno e Mare Adriatico, si conclude in queste settimane con la presentazione del documentario “Fermare l’estinzione”. Un filmato che raccoglie le tappe salienti del lavoro portato avanti dai biologi italiani e sloveni che hanno gettato le basi per salvare dall’estinzione la nacchera di mare o Pinna nobilis, una delle specie simbolo del Mare Nostrum, presente fino al 2016 con distese di migliaia di individui, ma colpita nell’ultimo decennio da un’epidemia causata da più fattori che ne ha decimato le popolazioni.

La sua rarità è tale che persino gli avvistamenti segnalati dai subacquei sono oggi accolti con cautela dagli scienziati. A complicare il riconoscimento è infatti la crescente presenza sui nostri fondali della Pinna rudis, una specie simile di origine subtropicale, la cui diffusione è favorita dal riscaldamento globale e dall’arrivo di fauna “aliena” attraverso il Canale di Suez.
Ma perché è così fondamentale proteggerla? Perdere per sempre la Pinna nobilis avrebbe conseguenze molto gravi per la salute e la ricchezza dei nostri mari. La nacchera, infatti, è una specie chiave dei fondali sabbiosi e delle praterie di Posidonia oceanica, dove contribuisce a dar vita a uno degli ecosistemi più complessi e preziosi, offrendo rifugio e sostegno ad altre specie, in particolare a quelle filtratrici e sospensivore, e agendo al contempo essa stessa come un potente filtro biologico che riduce la torbidità delle acque. Si stima che un individuo adulto arrivi a filtrare 3.000 litri d’acqua in un giorno.
“Nel corso del progetto, gli scienziati di LIFE Pinna si sono dovuti confrontare con una recrudescenza dell’epidemia che ha reso problematico il reperimento di individui vivi”, spiega Daniela Caracciolo di ARPAL, coordinatrice del progetto. “Grazie al grande impegno profuso, i ricercatori sono comunque riusciti a svolgere le principali attività previste: dalle analisi sulla variabilità genetica dei superstiti per individuare i più resistenti alle infezioni, e dunque i migliori candidati a generare discendenza, ai trapianti di individui vivi sani in aree marine considerate idonee e sgombre da parassiti”, conclude Caracciolo.
Durante l’allevamento temporaneo in cattività delle Pinne, inoltre, i ricercatori sono riusciti a ottenere la fertilizzazione e a portare lo sviluppo larvale a uno stadio mai raggiunto in precedenza per questa specie. Poiché LIFE PINNA è stato pensato per essere replicato in altri contesti, i ricercatori hanno messo a punto dei protocolli operativi per tutte le fasi, dal monitoraggio all’allevamento fino alla reintroduzione in natura. È solo una delle eredità lasciate dal progetto.
All’evento finale, che si svolgerà il 17 settembre a Pirano (Slovenia), nella Stazione di Biologia Marina sede dell’Istituto Nazionale di Biologia (NIB), ci sarà infatti una tavola rotonda a cui parteciperanno decine di scienziati e i rappresentanti delle istituzioni italiane, slovene ed europee per capitalizzare l’esperienza del progetto e definire le prossime azioni concrete di conservazione della specie.(30Science.com)