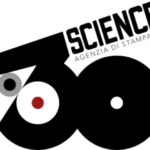Roma – Una sequenza del genoma pressoché ininterrotta dell’echidna, un mammifero oviparo dotato di molteplici cromosomi sessuali, aiuta i ricercatori a tracciare gli eventi di riorganizzazione genomica che hanno dato origine a un sistema di determinazione del sesso del tutto insolito.
L’echidna dal becco corto ( Tachyglossus aculeatus ) è uno degli animali più iconici dell’Australia. Appartiene a un gruppo unico di mammiferi chiamati “monotremi” (con l’ornitorinco come altro membro di spicco). Gli echidna possono a prima vista essere scambiati per uno strano riccio, ma sono in realtà mammiferi che depongono le uova. Un team internazionale di ricercatori, guidato da Guojie Zhang e Qi Zhou della Zhejiang University , Yang Zhou della BGI-research e Frank Grutzner dell’Adelaide University, ha ora fornito una sequenza del genoma quasi senza interruzioni dell’echidna dal becco corto. Gli autori hanno utilizzato i nuovi dati per comprendere meglio l’origine evolutiva della configurazione altamente complessa di più cromosomi sessuali, caratteristica dei monotremi. Il lavoro è pubblicato sulla rivista scientifica aperta GigaScience .
Tra le tante caratteristiche insolite dei monotremi, una è la loro posizione nell’albero della vita: si sono separati dagli altri mammiferi molto presto, diventando il ramo più antico dell’albero dei mammiferi. Ciò si riflette nei loro genomi e, in particolare, nel modo in cui il sesso è determinato geneticamente. Nella maggior parte dei sistemi di determinazione del sesso, i cromosomi sessuali sono tipicamente in coppia, come nel familiare sistema X/Y negli esseri umani e nella maggior parte degli altri mammiferi. In questa configurazione ben nota, il sesso è determinato principalmente dalla coppia di cromosomi sessuali che la prole eredita. Lo spermatozoo trasporta un cromosoma X o Y e l’uovo può trasportare solo un cromosoma X. Al momento della fecondazione, il sesso della prole è determinato principalmente da quale dei cromosomi dello spermatozoo entra nell’uovo, con le femmine che hanno due cromosomi X e i maschi che hanno un X e un Y.
Al contrario, i monotremi hanno un sistema di determinazione del sesso molto più complesso, caratterizzato da più cromosomi X e Y. Inoltre, ci sono anche delle differenze tra i due gruppi di monotremi che separano le echidne e le famiglie degli ornitorinchi. Nell’echidna maschio ci sono nove cromosomi sessuali mentre l’ornitorinco ne ha dieci. L’echidna maschio ha cinque cromosomi X, ma solo quattro cromosomi Y; mentre l’ornitorinco maschio ne ha cinque X e cinque Y). Durante la produzione di sperma e uova (meiosi), questi cromosomi sessuali si accoppiano in modo testa-coda e formano catene, piuttosto che l’accoppiamento fianco a fianco tipicamente osservato negli organismi con solo 2 cromosomi sessuali. L’accoppiamento testa-coda nei monotremi consente ai cromosomi di essere distribuiti in modo ordinato alle cellule germinali e in un modo che non porta a problemi genetici.
La sequenza del genoma dell’echidna qui fornita aiuta i ricercatori a tracciare gli eventi genetici che hanno portato a questa straordinaria disposizione cromosomica. La sequenza di alta qualità con pochissime lacune qui presentata consente agli scienziati di dedurre eventi come riarrangiamenti cromosomici nella linea di discendenza dei monotremi.
Zhang afferma che “il genoma di riferimento di alta qualità dell’echidna ci consente di dedurre quali cromosomi sono condivisi tra echidna e ornitorinco da quando si sono separati dagli altri mammiferi e quali [cromosomi] si sono evoluti di recente dopo la separazione delle due famiglie monotreme”. I lignaggi evolutivi di echidna e ornitorinco si sono separati circa 55 milioni di anni fa e ci sono prove che eventi di fusione e fissione dei cromosomi potrebbero essersi verificati dalla loro divergenza.
Utilizzando sia la nuova sequenza del genoma dell’echidna sia una sequenza del genoma dell’ornitorinco esistente, il team internazionale di ricercatori ha ricostruito la probabile composizione cromosomica dell’antenato monotrema. Hanno anche utilizzato assemblaggi cromosomici di placentati (umani, bovini e bradipi), marsupiali (opossum e diavolo della Tasmania) e gruppi esterni di rettili (polli, tartarughe e la comune lucertola muraiola) nella loro ricerca. L’analisi di questi cromosomi sessuali ha rivelato che il cromosoma X ancestrale dei monotremi aveva scambiato segmenti con cromosomi non sessuali ancestrali (autosomi), che hanno dato origine al loro complesso sistema.
Oltre a questi cambiamenti strutturali nell’organizzazione del genoma, gli autori hanno anche trovato segnali di espansione della famiglia genica, il che significa che copie aggiuntive di geni specifici sono sorte durante l’evoluzione dei monotremi. Uno di questi eventi riguarda un gene chiamato SYCP3Y. Questo gene codifica un componente di una struttura proteica chiamata complesso sinaptonemale, che collega le coppie di cromosomi durante la formazione delle cellule germinali. SYCP3Y è duplicato dagli autosomi ed espanso sia nell’ornitorinco che nell’echidna, il che suggerisce che l’espansione genica potrebbe essere associata all’evoluzione del complesso dei cromosomi sessuali o svolgere un ruolo nella sua organizzazione.
Nel complesso, i nuovi risultati forniscono una storia evolutiva dettagliata del sistema altamente insolito dei cromosomi sessuali multipli nei monotremi e dimostrano come gli attuali metodi genomici ad alta risoluzione possano scoprire eventi evolutivi complessi che hanno plasmato l’albero della vita dei mammiferi milioni di anni fa. I dettagli di questo processo e l’intrigante domanda su come e perché questo complicato sistema abbia avuto origine in primo luogo sono ancora oggetto di ricerca in corso, ma i dati qui ci portano un passo avanti nella comprensione di questi eventi e contribuiscono a rispondere a queste domande.(30Science.com)