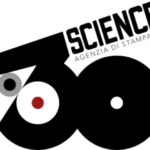Roma – A seconda di dove vivono gli uccelli, alcuni di loro potrebbero preferire compagni con un petto più chiaro, mentre altri trovano più attraente un petto più rosso. La differenza in ciò che questi uccelli preferiscono quando si tratta di scegliere un compagno sta aiutando gli scienziati a svelare uno dei più grandi misteri della biologia: come hanno origine le nuove specie.
In un nuovo studio condotto dall’Università del Colorado a Boulder, i biologi hanno utilizzato il sequenziamento genetico di rondini di tutto il mondo per fornire prove in tempo reale del fatto che la selezione sessuale, in cui gli organismi scelgono i partner in base alle caratteristiche che ritengono attraenti, determina l’emergere di nuove specie. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science . “Questo è uno dei primissimi articoli a mostrare in modo esaustivo il ruolo delle decisioni di selezione del partner nell’evoluzione di nuove specie”, ha affermato Rebecca Safran , autrice senior dell’articolo e professoressa presso il Dipartimento di ecologia e biologia evolutiva. Le nuove scoperte gettano luce su come si formano le nuove specie, un processo fondamentale ma sfuggente per tutta la vita sulla Terra.
Charles Darwin propose la teoria della selezione sessuale nel 1875. Essa suggerisce che gli organismi evolvono tratti vistosi, come piumaggi stravaganti o mosse di danza accattivanti, per attrarre i compagni. Quando organismi della stessa specie sviluppano preferenze per tratti diversi e non si riproducono più tra loro, nel tempo potrebbero emergere nuove specie, un processo noto come speciazione.
Negli ultimi 150 anni, i ricercatori della selezione sessuale hanno studiato principalmente organismi che si erano già diversificati in specie distinte. Ad esempio, le orchidee, che ora comprendono più di 25.000 specie, hanno avuto origine da un antenato comune. La loro notevole diversità porta spesso a supporre che abbiano sviluppato aspetti diversi per attrarre diversi impollinatori, ha affermato Drew Schield , primo autore del documento e professore associato presso l’Università della Virginia.
“È logico pensare in questo modo e potrebbe essere del tutto vero”, ha detto Schield, che ha svolto la ricerca mentre era ricercatore post-dottorato presso la CU Boulder. “Ma con la speciazione già avvenuta, è impossibile saperlo con certezza”. Di conseguenza, è stato difficile trovare prove dirette che la selezione sessuale guidi l’emergere di nuove specie. Le rondini rappresentano un’opportunità unica per esplorare il processo di speciazione mentre si svolge. Questi uccelli sono una delle specie più comuni e diffuse sul nostro pianeta. Attualmente, ci sono sei sottospecie di rondini, ognuna delle quali sembra leggermente diversa per alcuni tratti critici per le decisioni sulla scelta del partner, a seconda di dove si trovano.
Ad esempio, il gruppo dell’Asia orientale, Hirundo rustica gutturalis, ha un petto pallido e strisce di coda più corte, ovvero le penne esterne allungate della coda. Hirundo rustica tytleri, trovato in Siberia, ha lunghe strisce di coda e penne rosse sul petto. La sottospecie in Europa e nell’Asia occidentale, Hirundo rustica rustica, ha un petto pallido e lunghe strisce di coda.
Le prove suggeriscono che gli antenati dell’uccello lasciarono la valle del Nilo nell’Africa settentrionale circa 11.000 anni fa e si diffusero nell’emisfero settentrionale. Per migliaia di anni, popolazioni diverse interagirono a malapena e svilupparono tratti diversi, formando sottospecie.
Circa 800-2000 anni fa, alcune sottospecie hanno espanso i loro territori e gli habitat hanno iniziato a sovrapporsi. In alcune parti del mondo, le sottospecie ora interagiscono tra loro, producendo prole ibrida.
Safran e il suo team hanno deciso di indagare se la selezione sessuale in questi uccelli fosse il motore del processo di speciazione.
Il team, tra cui Elizabeth Scordato, professore associato presso la California State Polytechnic University, ha sequenziato i genomi di 336 rondini provenienti da tutto il mondo, comprendenti tutte le sottospecie e tre zone ibride, dove le sottospecie si incrociano, in Eurasia.
I ricercatori hanno scoperto una dozzina di regioni nel genoma delle rondini associate a due tratti sessualmente selezionati di questi uccelli: la colorazione ventrale (il colore del piumaggio del petto e del ventre) e la lunghezza della coda.
Quando gli individui si riproducono, i geni di entrambi i genitori si rimescolano e si combinano per formare i geni della loro prole. Quando due popolazioni si incontrano, il flusso di materiale genetico dall’una all’altra è un indicatore di quanto siano simili le popolazioni. Se il tasso di flusso genico è basso, significa che le due popolazioni si riproducono tra loro a un tasso inferiore rispetto a quello che farebbero se fossero della stessa specie.
Lo studio ha scoperto che nelle zone ibride delle rondini gran parte dei loro geni fluisce liberamente tra i gruppi. Ma le regioni genetiche che codificano per la colorazione ventrale e la lunghezza del nastro della coda difficilmente si trasferiscono ad altre popolazioni.
Ciò suggerisce che tra gli individui ibridi con genitori di sottospecie diverse, un piccolo numero di uccelli fortunati che ereditano una combinazione favorevole di geni del colore ventrale e dello streamer della coda sono in grado di attrarre i compagni. Gli ibridi che ricevono combinazioni meno favorevoli tendono ad avere meno successo nella riproduzione.
“Questi geni stanno raggiungendo un limite a causa della selezione sessuale divergente e smettono di spostarsi da una popolazione all’altra”, ha affermato Schield.
Le diverse preferenze per la lunghezza delle penne della coda e il colore del petto tra le sottospecie rendono le rondini più propense ad accoppiarsi all’interno del loro stesso gruppo, ha aggiunto Schield. Se la tendenza continua, questi gruppi non potrebbero più incrociarsi o produrre prole, marcatori per la formazione di specie separate.
Successivamente, il team prevede di campionare più uccelli e studiare se l’essere un ibrido influisca sul successo riproduttivo.
“È davvero fantastico che siamo riusciti a catturare un ritratto evolutivo in tempo reale di questo comune animale e a capire come e perché le popolazioni stanno divergendo”, ha detto Safran. “La nostra comprensione del processo è di fondamentale importanza per affrontare un’ampia gamma di questioni relative alla biodiversità, all’evoluzione e alla conservazione”.(30Science.com)