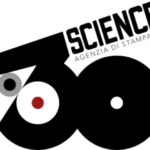Roma – È stato geneticamente confermato che la farfalla blu dell’Atlante, nota anche come Polyommatus atlantica , ha il numero più alto di cromosomi tra tutti gli animali multicellulari del mondo. Questo insetto vanta 229 coppie di cromosomi, mentre molti dei suoi parenti stretti ne hanno solo 23 o 24. I ricercatori del Wellcome Sanger Institute e dell’Istituto di Biologia Evoluzionistica (IBE: CSIC-UPF) di Barcellona hanno scoperto che questi cromosomi si sono frammentati nel tempo, anziché duplicarsi. Il primo studio genomico di questa farfalla, pubblicato su Current Biology , consente agli esperti di iniziare a esplorare le ragioni evolutive alla base di questo numero estremo di cromosomi. I cambiamenti cromosomici si osservano anche nelle cellule tumorali umane e, pertanto, comprendere questo processo in diverse specie potrebbe contribuire a informare la ricerca sul cancro.
Questa è la prima volta che la farfalla blu dell’Atlante viene sequenziata. Da questa analisi, gli esperti hanno prodotto un genoma di riferimento di riferimento per questa specie, consentendo ai ricercatori di confrontare questo genoma estremo con quello di altre farfalle e falene per comprendere meglio come le specie si formano e cambiano nel tempo.
L’evoluzione e lo sviluppo di nuove specie avvengono nel corso di milioni di anni, rendendo difficile studiarli in modo pratico. Invece, gli esperti possono utilizzare il DNA di una specie e confrontarlo con quello di altre specie della stessa famiglia per capire quali geni e tratti sono stati conservati e quali sono andati perduti, e quindi formulare ipotesi fondate sul perché.
Conoscere la storia genetica di una specie ci permette anche di capire come potrebbe evolversi il capitolo successivo. Ad esempio, potremmo capire come una specie potrebbe rispondere all’aumento della temperatura globale e se possiede geni o meccanismi che potrebbero proteggerla. Questo potrebbe orientare gli sforzi di conservazione e la ricerca sulla produzione di colture più resilienti.
La farfalla blu dell’Atlante è diffusa nelle catene montuose del Marocco e del nord-est dell’Algeria. Sebbene si sospettasse che avesse il maggior numero di coppie cromosomiche nel regno animale, questa è la prima volta che gli esperti hanno sequenziato il genoma della farfalla per confermarlo . A titolo di confronto, un parente stretto ampiamente diffuso nel Regno Unito, la farfalla blu comune, ha 24 cromosomi.
Si ritiene che i cambiamenti nel numero dei cromosomi contribuiscano al processo di formazione di nuove specie e aiutino le specie ad adattarsi al loro ambiente. Il gruppo a cui appartiene la farfalla blu dell’Atlante comprende molte specie strettamente correlate che si sono evolute in un breve periodo di tempo.
In questa nuova ricerca, il team ha scoperto che i cromosomi erano stati divisi in punti in cui il DNA era meno strettamente avvolto. Ciò significa che c’era all’incirca la stessa quantità di informazioni genetiche, ma era impacchettata in sezioni più piccole. Tutti i cromosomi, a parte i cromosomi sessuali, erano divisi e i ricercatori stimano che ciò abbia causato il passaggio del numero di cromosomi da 24 a 229 nell’arco di circa tre milioni di anni, un lasso di tempo relativamente breve per gli standard evolutivi.
Di solito si presume che questo tipo di mutazione cromosomica estrema sia negativa; tuttavia, la farfalla blu dell’Atlante si è evoluta ed è sopravvissuta per milioni di anni. Solo ora, a causa dei cambiamenti climatici e dell’impatto umano sull’ambiente, come la distruzione delle foreste di cedri e il sovrapascolo, le sue popolazioni sono minacciate.
Questa ricerca solleva molteplici interrogativi che potranno essere affrontati in futuro. La suddivisione dei cromosomi potrebbe contribuire a una maggiore diversità genetica consentendo un rimescolamento più frequente delle parti del genoma o apportare altri benefici sconosciuti. Sebbene ciò possa aiutare le farfalle ad adattarsi rapidamente, le specie con molti cromosomi potrebbero anche dover affrontare sfide dovute alla maggiore complessità di questo processo, rendendole potenzialmente più vulnerabili all’estinzione nel tempo. Ulteriori indagini e confronti con altre farfalle potrebbero evidenziare se alcuni geni sono andati perduti o preservati, fornendoci maggiori informazioni sulla biologia delle farfalle, ma anche una comprensione più approfondita dell’evoluzione.
Anche nei tumori umani si verificano riarrangiamenti cromosomici e, pertanto, studiare questi processi nel DNA della farfalla blu Atlas potrebbe portare a nuovi sviluppi nella salute umana e mettere in luce possibili modi per ridurre o arrestare questo fenomeno nelle cellule tumorali.
Roger Vila, autore senior dell’Istituto di Biologia Evoluzionistica, ha affermato: “La scomposizione dei cromosomi è stata osservata in altre specie di farfalle, ma non a questo livello, il che suggerisce che ci sono ragioni importanti per questo processo che ora possiamo iniziare a esplorare. Inoltre, poiché i cromosomi custodiscono tutti i segreti di una specie, indagare se questi cambiamenti influenzino il comportamento di una farfalla potrebbe aiutare a formare un quadro completo di come e perché si formano nuove specie”.
Charlotte Wright, prima autrice del Wellcome Sanger Institute, ha dichiarato: “Quando abbiamo iniziato a comprendere l’evoluzione delle farfalle, sapevamo di dover sequenziare la più estrema e misteriosa delle farfalle blu dell’Atlante. Grazie a Roger Vila, che aveva già collaborato con il suo collega per trovare e identificare questa sfuggente farfalla, siamo stati in grado di sequenziare questa specie, evidenziando la natura collaborativa della scienza. Potendo osservare, in dettaglio, come i cromosomi delle farfalle blu dell’Atlante si siano divisi nel tempo in luoghi specifici, possiamo iniziare a indagare quali benefici ciò possa avere, come influisca sulla loro capacità di adattamento all’ambiente e se ci siano lezioni che possiamo imparare dal loro DNA che potrebbero aiutare la conservazione in futuro”.
Mark Blaxter, autore senior del Wellcome Sanger Institute, ha affermato: “I genomi sono la chiave per comprendere come una creatura è nata, ma anche dove potrebbe evolversi in futuro. Per poter raccontare la storia del nostro pianeta, dobbiamo conoscere la storia di ogni specie e vedere dove si sovrappongono e interagiscono tra loro. Questo ci permette anche di applicare gli insegnamenti di un genoma all’altro. Ad esempio, la riorganizzazione dei cromosomi è osservata anche nelle cellule tumorali umane, e comprendere questo processo nella farfalla blu dell’Atlante potrebbe aiutare a trovare modi per limitarlo o bloccarlo nelle cellule tumorali in futuro”.(30Science.com)