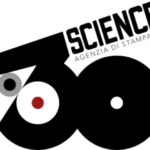Roma – È come se l’universo neonato avesse preso il morbillo. Da quando l’osservatorio JWST della NASA ha iniziato a scrutare l’universo distante nel 2022, ha scoperto un’ondata di “puntini rossi”: centinaia di essi, che brillavano nei primi miliardi di anni dell’universo di 13,8 miliardi di anni, così piccoli e rossi da sfidare ogni spiegazione convenzionale. Solo negli ultimi mesi si è iniziato a delineare un quadro. I puntini rossi, affermano gli astronomi, potrebbero essere un tipo di oggetto completamente nuovo: una colossale sfera di gas luminoso e caldo, più grande del Sistema Solare, alimentata non dalla fusione nucleare, ma da un buco nero.
“Penso che ci stiamo avvicinando a una risposta”, afferma Jenny Greene, astrofisica della Princeton University. Gli oggetti, che alcuni astronomi chiamano “stelle-buco nero”, potrebbero rappresentare l’anello mancante nell’evoluzione delle galassie e contribuire a spiegare la rapida crescita dei buchi neri supermassicci che si trovano al loro centro. “La grande svolta degli ultimi 6 mesi è in realtà la consapevolezza che possiamo scartare tutti gli altri modelli con cui abbiamo giocato finora”, afferma l’astronoma Anna de Graaff del Max Planck Institute for Astronomy.
Con il suo gigantesco specchio da 6,5 metri, il JWST è il telescopio più potente mai lanciato nello spazio. Quasi immediatamente, ha iniziato a trovare molte più galassie grandi e mature di quanto ci si aspettasse nell’universo infantile. Inizialmente, gli osservatori pensavano che i piccoli punti rossi potessero essere galassie mature, che tendono a diventare più rosse con l’invecchiamento delle stelle. Ma il JWST non riusciva a risolvere i punti in una forma riconoscibile, il che significava che dovevano essere minuscoli: meno del 2% del diametro della Via Lattea. “Era un mistero… il motivo per cui fossero così spazialmente compatte”, afferma Caitlin Casey dell’Università del Texas ad Austin. Sarebbe stato necessario un accumulo di stelle incredibilmente denso per spiegare la loro luminosità. “Ero emozionato”, dice Casey. Le dimensioni compatte sarebbero più facili da spiegare se la luce non provenisse da innumerevoli stelle, ma da un buco nero supermassiccio. Questi oggetti, con una massa pari a milioni o miliardi di volte quella del Sole, si trovano al centro della maggior parte delle galassie, a volte divorando la materia circostante e riscaldandola così tanto da brillare intensamente. Ma questi buchi neri brillano anche nell’ultravioletto (UV) e nei raggi X. I piccoli puntini rossi, d’altra parte, emettono debolmente nell’UV e, per quanto gli astronomi si siano sforzati, non emettono affatto nei raggi X. “Molto rapidamente hanno iniziato a emergere una serie di peculiarità che hanno dimostrato che questi oggetti non assomigliano in realtà a nessuna delle classi di oggetti che conoscevamo”, afferma Rohan Naidu del Massachusetts Institute of Technology.
Molti pensavano che un velo di polvere potesse spiegare ciò che stavano osservando. La polvere può assorbire i raggi UV e X – nascondendoli agli osservatori – e riemetterli a lunghezze d’onda più rosse e persino più lunghe, nel medio infrarosso e nelle lunghezze d’onda millimetriche. Gli astronomi hanno utilizzato il Mid-Infrared Instrument (MIRI) del JWST e l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile per cercare quella riemissione a lunghezza d’onda maggiore. Ma ALMA non ha rilevato nulla nelle posizioni di 60 piccoli punti rossi noti, ha riferito un team guidato da Casey a maggio. Anche MIRI non ha trovato nulla. “Si è rivelato molto decisivo”, dice Greene. “Non sono polverosi… quello che stiamo vedendo è in realtà la luce che proviene da questa cosa, qualunque essa sia.”
A marzo, i team guidati da de Graaff e Naidu hanno pubblicato le analisi della luce emessa da un particolare puntino rosso. Scomposta nel suo spettro, la luce mostrava l’ampia emissione ottica tipica di una stella con picco nel rosso, punteggiata da strette linee di assorbimento dove l’idrogeno nell’atmosfera stellare assorbe determinate lunghezze d’onda. Inoltre, lo spettro conteneva linee di emissione luminose, caratteristiche del gas surriscaldato attorno a un buco nero attivo, che vengono ampliate dagli spostamenti Doppler dovuti alla velocità delle particelle di gas.Entrambi i team giungono quindi a una nuova, audace immagine: il piccolo puntino rosso è uno spesso bozzolo gassoso, non dissimile da un’atmosfera stellare, che circonda un buco nero attivo. La radiazione del buco nero riscalda e sostiene il guscio di gas, che è così denso da assorbire i raggi UV e X più energetici. “In pratica, il gas è opaco e quindi irradia come una stella”, afferma Greene.
Per Mitch Begelman, astrofisico teorico dell’Università del Colorado a Boulder, le osservazioni sono una conferma. All’inizio di questo mese, lui e un collega hanno pubblicato un preprint su arXiv, riproponendo uno scenario per la formazione di ipotetiche “quasi-stelle” che lui e altri avevano proposto 20 anni fa.
La prima generazione di stelle, hanno calcolato, avrebbe potuto raggiungere dimensioni colossali nell’universo primordiale, costituito quasi interamente da idrogeno, la materia prima delle stelle. Quando una stella gigante esauriva il combustibile, hanno detto, il suo nucleo sarebbe collassato in un buco nero, ma l’involucro esterno di idrogeno era così denso da sopravvivere all’esplosione, racchiudendo il buco nero neonato. Mentre il buco nero divorava il suo velo di gas, l’intero sistema brillava come una quasi-stella più grande del Sistema Solare. “Questo è ciò che fa l’involucro della quasi-stella: alimenta forzatamente il buco nero spingendo materia al suo interno”, dice Begelman.
Considerata la frequenza con cui i piccoli puntini rossi sembrano essere presenti nell’universo primordiale, i teorici stanno iniziando a chiedersi se questa fase di gigantesca sfera di gas sia una parte essenziale della crescita dei buchi neri e dell’evoluzione delle galassie. “Probabilmente stiamo assistendo a una nuova fase di crescita dei buchi neri di cui non eravamo a conoscenza prima”, afferma de Graaff. Greene concorda: “Posso immaginare perfettamente che la Via Lattea fosse un piccolo puntino rosso che ha dato inizio al suo buco nero e poi ha continuato a funzionare per il resto del tempo cosmico”.
La grande distanza e le piccole dimensioni dei punti rendono estremamente difficile dare corpo a questa immagine. “Non sappiamo praticamente nulla delle galassie che li ospitano perché non possiamo vederle”, afferma Casey.
La situazione potrebbe cambiare con la segnalazione, questo mese, di una manciata di oggetti molto più vicini alla Terra che sembrano piccoli puntini rossi. Xiaojing Lin della Tsinghua University e i suoi colleghi hanno trovato diversi buoni candidati a soli 2,5 miliardi di anni luce di distanza in una scansione dei dati di una precedente campagna di osservazione, la Sloan Digital Sky Survey. Una sorgente era stata ripresa dal telescopio spaziale Hubble diversi anni fa. “Vediamo una galassia compatta e relativamente debole lì”, dice Lin. Al suo team è stato recentemente concesso più tempo su Hubble per un’osservazione più ravvicinata. Sperano di vedere “se ci sono molte interazioni, attività, flussi in entrata e in uscita, qualsiasi cosa stia accadendo” che potrebbero rivelare il funzionamento di una stella buco nero, afferma Xiaohui Fan, membro del team dell’Università dell’Arizona.
Se i puntini rossi si rivelassero effettivamente stelle buco nero, sarebbe esattamente il tipo di svolta che ci si aspetta dal JWST, e il tipo di scoperta per cui gli astronomi vivono. Svelare il mistero dei piccoli puntini rossi è “stata l’esperienza più divertente della mia carriera”, afferma Greene.(30Science.com)