Roma – Nel cuore della Birmania, nel marzo 2025, la Terra ha rivelato uno dei suoi segreti più violenti e inattesi: una frattura sismica capace di correre più veloce del suono. Un team internazionale guidato da Shujie Wei, del Department of Earth and Space Sciences della Peking University, ha documentato in un articolo pubblicato su Science un fenomeno estremo di “rottura supershear” avvenuto lungo la faglia di Sagaing, il sistema tettonico che attraversa il Myanmar da nord a sud e che segna il confine tra la placca indiana e quella della Sonda. L’evento, di magnitudo Mw 7.8, è stato registrato il 12 marzo 2025 e ha devastato ampie porzioni delle regioni centrali del Paese. Ma ciò che ha sorpreso i sismologi non è stata solo la potenza del terremoto, bensì la sua dinamica: la rottura si è propagata a una velocità superiore a 5 chilometri al secondo, cioè oltre la velocità delle onde di taglio (S-waves) nella crosta terrestre. “È come un aereo che supera il muro del suono”, spiega Wei. “Solo che in questo caso il boom sonico è avvenuto sotto i nostri piedi, lungo una faglia spessa più di 10 chilometri e lunga quasi 250”. Il fenomeno della rottura supershear è noto da tempo, ma fino a oggi era stato osservato quasi esclusivamente in contesti geologici molto rigidi e lineari, come nelle faglie californiane o oceaniche. Il terremoto birmano rappresenta la prima prova che una rottura supersonica può sostenersi a lungo anche all’interno di una faglia spessa e complessa, dove la struttura geologica dovrebbe, in teoria, dissipare energia e rallentare la propagazione. Attraverso un’integrazione di dati satellitari (SAR e InSAR), modelli geodetici, registrazioni accelerometriche e simulazioni numeriche, i ricercatori hanno ricostruito in tre dimensioni la dinamica della faglia. I risultati mostrano che la rottura ha iniziato la sua corsa a velocità subsonica, accelerando progressivamente fino a raggiungere e mantenere un regime supershear per oltre 200 chilometri.
Le misure di deformazione e le analisi termomeccaniche indicano che l’energia rilasciata ha prodotto stress transitori di oltre 20 megapascals, valori in grado di innescare onde di shock simili a quelle di un’esplosione. Il passaggio in regime supershear genera un fenomeno noto come Mach front, un fronte d’urto che si propaga nel sottosuolo e amplifica la distruzione in superficie. “È come se l’energia si concentrasse lungo una lama in movimento”, spiega Wei. “Le onde si sommano anziché disperdersi, creando un effetto di risonanza capace di moltiplicare i danni anche a decine di chilometri di distanza”. Nel caso del Myanmar, la propagazione supershear è stata sostenuta da una combinazione di fattori geologici: la grande continuità della faglia di Sagaing, la presenza di un ampio “damage zone” a basso attrito e l’elevata pressione dei fluidi interstiziali. Questi elementi hanno reso la faglia una sorta di condotto sismico naturale, in grado di mantenere la velocità critica senza interrompersi. Secondo Wei e colleghi, gli eventi supershear sono probabilmente più frequenti di quanto si pensasse e potrebbero spiegare perché alcuni terremoti producono danni sproporzionati rispetto alla loro magnitudo. “Fino a oggi tendevamo a considerare la velocità di rottura un parametro secondario”, osserva Wei. “In realtà, il modo in cui una faglia si muove può essere tanto determinante quanto la sua energia complessiva. Una rottura che corre più veloce del suono può amplificare le onde di superficie e modificare radicalmente la distribuzione dello scuotimento”. L’analisi comparativa condotta nel Supplementary Online Material del paper dimostra che i profili di deformazione e gli spettri di velocità del Myanmar coincidono con quelli di altri rari eventi supershear documentati, come il terremoto del Kunlun (Cina, 2001) e quello di Denali (Alaska, 2002). Ma, a differenza di questi casi, il sisma birmano si è verificato in un contesto continentale tropicale, caratterizzato da faglie di spessore maggiore e substrati sedimentari più complessi. “Questo significa che anche regioni come la Turchia, l’Iran o l’Himalaya potrebbero ospitare terremoti capaci di innescare lo stesso tipo di dinamica”, scrivono gli autori. Il team di ricerca – che comprende scienziati di Peking University, China Earthquake Administration, Caltech, University of Cambridge e Università di Tokyo – sottolinea che i modelli numerici di nuova generazione dovranno integrare parametri fisici reali della crosta (attrito, fluidi, porosità, anisotropie) per simulare la propagazione in regime supershear. Grazie ai sensori GNSS e radar ad altissima risoluzione, gli autori sono riusciti a mappare il campo di spostamento con una precisione di pochi millimetri, documentando deformazioni laterali superiori ai 9 metri in alcuni tratti della faglia. “È una sfida per la fisica dei terremoti”, conclude Wei. “Dobbiamo ripensare il modo in cui la Terra rilascia la sua energia: non come un’esplosione improvvisa, ma come un’onda che corre, si trasforma e accelera fino a rompere le regole che credevamo immutabili”.(30Science.com)
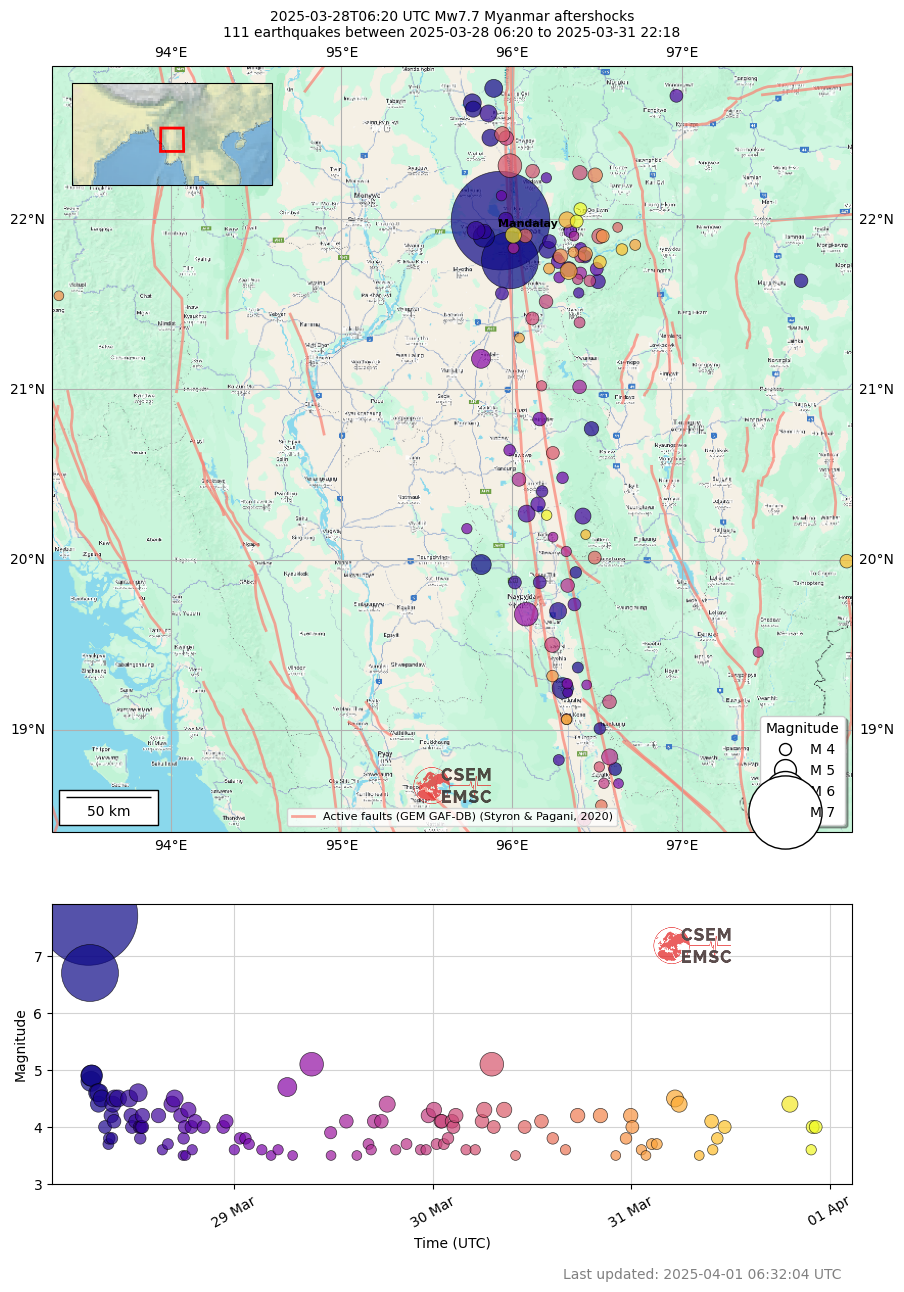
30Science.com
Il terremoto in Birmania ha prodotto una rottura della crosta che ha corso più veloce del suono
(30 Ottobre 2025)
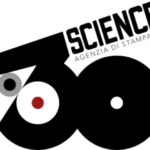
30Science.com
Agenzia di stampa quotidiana specializzata su temi di scienza, ambiente, natura, salute, società, mobilità e tecnologia. Ogni giorno produciamo una rassegna stampa delle principali riviste scientifiche internazionali e quattro notiziari tematici: Scienza, Clima & Natura, Salute, Nuova Mobilità e Ricerca Italiana
contatti:
redazione@30science.com
+ 39 3492419582